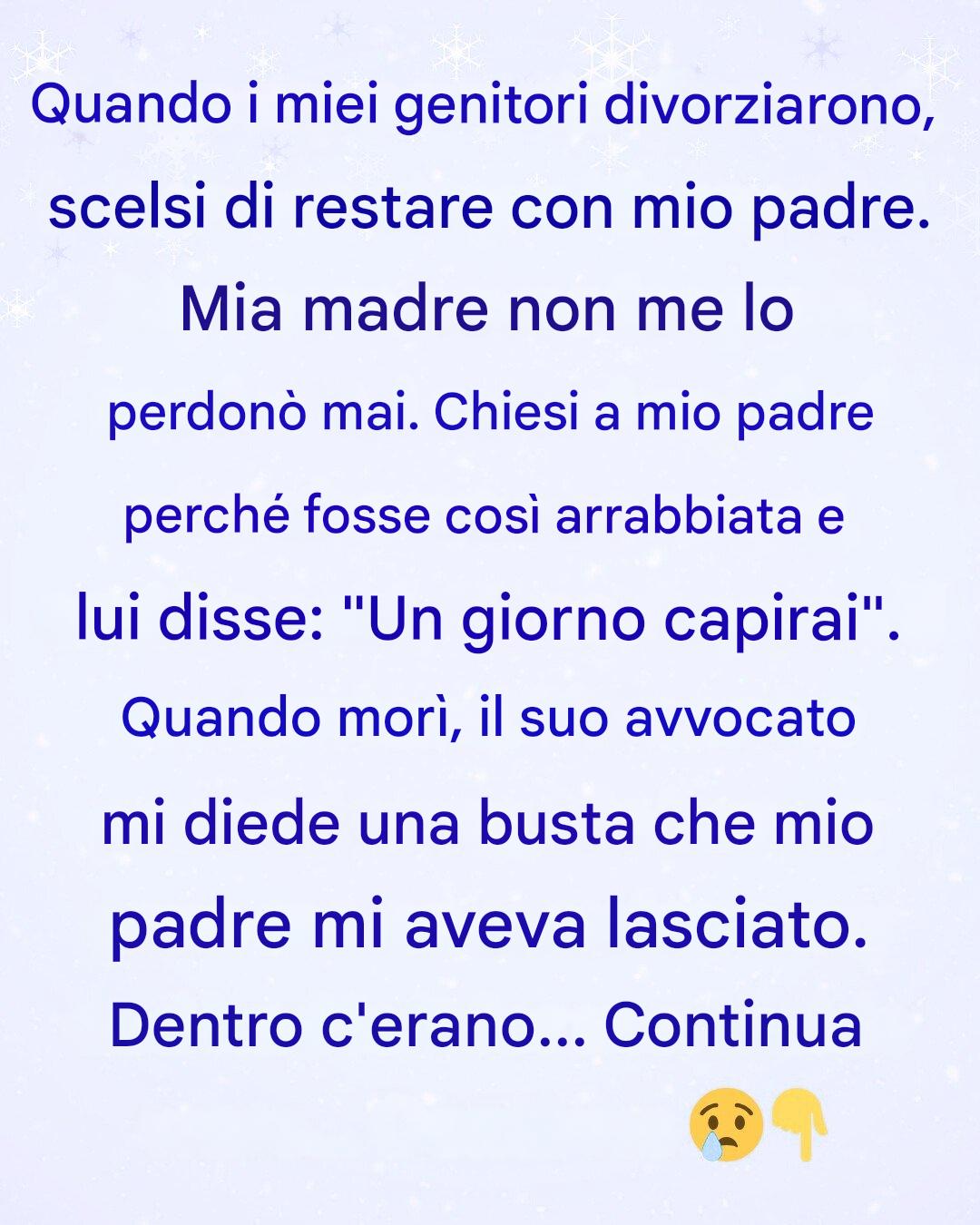Quando i miei genitori divorziarono, il mondo che conoscevo si spaccò nettamente a metà. Tutti continuavano a chiedermi con chi volessi vivere, come se un bambino potesse semplicemente scegliere tra due cuori. Alla fine, rimasi con mio padre. Lui cucinava i miei piatti preferiti, mi accompagnava a scuola e si assicurava sempre che mi sentissi al sicuro.
Mia madre, però, non mi ha mai perdonato. Almeno, questa è la sensazione che ho provato.
Ogni compleanno che perdeva, ogni telefonata brusca, ogni festività imbarazzante: ogni cosa creava un po’ più di distanza tra noi. Chiedevo a mio padre: “Perché è così arrabbiata con me? Cosa ho fatto di sbagliato?”. Lui mi scompigliava delicatamente i capelli e ripeteva ogni volta le stesse parole a bassa voce: “Un giorno capirai”.
Non capivo. Non quando avevo dodici anni. Non quando ne avevo diciotto. E certamente non il giorno in cui mi sono trovato al funerale di mio padre, stringendo un programma piegato con mani tremanti, desiderando di avere almeno un’altra possibilità di chiederglielo di nuovo.

Una settimana dopo, il suo avvocato mi chiamò nel suo ufficio. Mi fece scivolare una busta bianca sulla scrivania.
«Questo è da parte di tuo padre», disse dolcemente.
Il mio nome era scritto sul davanti con la calligrafia familiare e sicura di mio padre. Dentro, ho trovato una pila di ricevute – pagamenti di affitto, bollette, fatture mediche – ognuna con l’indirizzo di mia madre. Risalivano ad anni fa.
All’inizio non capivo cosa stessi guardando. Perché mio padre avrebbe dovuto conservare tutto questo?
Poi ho trovato il piccolo biglietto scritto a mano nascosto tra le pagine.